A dominare la tavola sono ancora oggi i piatti della cosiddetta cucina povera, quella gastronomia che nei secoli si è sviluppata a partire dai pochi ingredienti a disposizione, simbolo di ristrettezze ma anche dell’abilità degli abitanti di saper trasformare materie prime semplici e avanzi in piatti gustosi. Nonostante le sue umili origini, la cucina toscana vanta una serie di prodotti straordinari, tutti da scoprire. Ecco quali sono i più rappresentativi della regione.

Solitamente usato nella preparazione dei dolci (come le peschette ripiene), è un liquore preparato con alcol etilico, zucchero, acqua, cannella, chiodi di garofano, cardamomo, acqua di rose, lamponi e colorante rosso. In origine, per conferire colore veniva usato la cocciniglia.

Taglio di carne di vitellone di razza chianina o scottona, alto e con tanto di osso. Viene cotto alla brace o alla griglia e va servito al sangue.

Biscotti molto sottili, simili a sfoglie, tipici di Lamporecchio in provincia di Pistoia. La ricetta prevede farina 00, zucchero, uova, un pizzico di sale, un cucchiaio di semi di anice e, a piacere, una stecca di vaniglia. La tradizione li vuole cotti sulla brace, con stampi di ferro chiamate schiacce, sulle quali venivano un tempo poste le piccole palline di pasta da pressare e poi rimettere sul fuoco per qualche minuto.

La paternità dei brutti ma buoni è rivendicata sia da Pistoia che da Lucca. Si tratta di biscotti semplici e rustici, molto saporiti, a base di nocciole, mandorle, albumi e zucchero a velo.
Salame tipico della zona di Grosseto, prodotto con i tratti del budello suino conditi con aceto, aromi e spezie. Viene lasciato essiccare per circa 30 giorni.
Un guscio di pasta frolla ripieno di riso cotto lentamente in acqua o latte e aromatizzato con scorza di limone, vaniglia oppure liquore. Il risultato è una tortina croccante fuori e morbida all’interno, ricoperta con abbondante zucchero a velo.

Un“biscotto a fette, di fior di farina, con zucchero e chiara d’uovo”, è questa la definizione che nel 1691 l’Accademia della Crusca dà dei cantucci, probabilmente i biscotti più famosi della Toscana. Al contrario del biscotto di Prato, fatto con farina, zucchero, uova, mandorle e pinoli, il cantuccio presenta un impasto più ricco. Entrambi, vengono accompagnati da un buon bicchiere di Vin santo.
Dalla forma tonda e irregolare, il colore chiaro, è un cece duro e piccolo, prodotto da marzo ad agosto.

Versione toscana della farinata ligure, detta torta di ceci nella variante livornese. Una delle merende tipiche dei bambini, street food per eccellenza a base di farina di ceci insaporita con pepe in abbondanza. Si presenta bassa e croccante e viene solitamente consumata dentro il francesino, un pane lungo di farina di grano duro.
Una focaccia di piccole dimensioni, croccante fuori e morbida all’interno, preparata con farina di grano duro, lievito, sale, acqua, olio extravergine d’oliva o, nelle ricette più antiche, strutto.

Ne esistono due varietà principali: la statina, più tonda e dal colore violaceo, consumata in estate, e la vernina, schiacciata ai lati e di colore rosso intenso, presente a partire da fine agosto per tutto il periodo freddo.

Salame diffuso in tutto il territorio, a base di carne di maiale macinata e condita con semi di finocchio e vino rosso.

Gnocchetti a base di farina, spinaci o bietola (o altre verdure,) ricotta, formaggio grattugiato, spezie e alle volte anche uova, infarinati e cotti in acqua bollente per essere poi scolati non appena vengono a galla.
Formaggio di latte ovino dalla crosta naturale color giallastra e la pasta erborinata (per questo è detto anche “gorgonzola di pecora”). Si caratterizza da un profumo intenso e il gusto ricco e avvolgente.

Simile alla trippa, è fatto con lo stomaco abomaso, che comprende una parte magra e un’altra più grassa chiamata spannocchia. Dal colore scuro e la consistenza morbida, viene gustato tradizionalmente all’interno di un panino e servito nei chioschi in strada.
In Garfagnana, neccio vuol dire castagna. Molto diffuse in zona, dalle castagne secche si ricava una farina, qui chiamata farina di neccio, spesso utilizzata nella produzione dolciaria e protetta dalla denominazione d’origine. I necci sono cialde sottili e morbide, chiuse a mo’ di cannolo siciliano, preparate con farina di castagna e farcite con ricotta di mucca.

Indissolubilmente legato alla città di Siena, il panforte viene consumato oggi in tutto il territorio nazionale durante le feste di Natale. In origine, non era altro che una semplice focaccia a base di acqua, farina, miele e frutta inserita nell’impasto ancora cruda, dettaglio fondamentale perché – se non completamente asciutta – conferiva all’impasto un particolare sapore asprigno. Il nome, infatti, deriva da panis fortis, ovvero pane acido. Con l’arrivo delle spezie dall’Oriente, poi, la ricetta venne modificata e furono aggiunte cannella, cardamomo, chiodi di garofano e noce moscata. Erano infatti gli speziali, i farmacisti dell’epoca, a occuparsi della preparazione del dolce, non più alla portata di tutti ma destinato solo alle classi più abbienti. Ne esiste anche una versione tipicamente senese chiamata panforte Margherita, creata nel 1879 in occasione della visita della regina di Savoia, che si differenziava per la copertura di zucchero vanigliato al posto del pepe nero.
Un prodotto a metà fra schiacciata e piadina, cotto nei testi, ovvero piastre in terracotta di origini remote, già presenti in epoca bizantina. Si prepara con acqua, farina e sale.
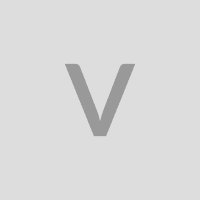
Un formato di pasta anticamente preparato con un impasto a base di acqua e farina, oggi disponibile anche nella versione all’uovo. Ragù di carni e cacciagione in questo caso la fanno da padrone: d’altronde, il nome stesso (dal termine dialettale toscano “pappare”) fa riferimento alla golosità del prodotto.

Formaggio a pasta dura a base di latte di pecora e stagionato in barriques, dal sapore intenso e persistente.

Spaghettoni irregolari ottenuti da una sfoglia piuttosto grossa, dalla quale si ricavano dei rombi che vengono poi fatti rotolare sulla spianatoia, per essere infine allungati con le mani fino a ottenere dei fili di pasta spessi e ruvidi.

Biscotti morbidi prodotti con pasta di mandorle, farina 00, canditi, zucchero a velo. L’impasto deve riposare per due giorni prima di essere infornato. La tradizione vuole che si mangino per le feste natalizie, ma ormai si producono durante tutto l’anno.
La cinta senese è una razza suina molto antica, già allevata al tempo dei romani. Da questa, si ricavano diversi salumi, dal prosciutto al guanciale, dal salame alla pancetta.

Sorta di focaccia bassa realizzata con farina di grano duro, acqua, (in alcuni casi latte o vino), sale e cotta nel forno a legna, pizzicata in superficie e condita con olio extravergine d’oliva. Nella versione contadina, all’interno dell’impasto si mettevano i ciccioli, che qui prendono il nome regionale di frizzoli. Tante le varianti in regione, fra cui quella di Grosseto, salata solo in superficie e spesso farcita con cipolle e acciughe, consumata come piatto unico al momento del pranzo. Un’altra versione celebre è la schiaccia pala di Montiano, una preparazione dalle grandi dimensioni (40-50 centimetri di diametro) prodotta con la pasta del pane e infornata sulle pale da pizza.

Delle crespelle cotte nel testo, tortiera dal bordo basso un tempo in terracotta, oggi in ghisa o ferro, molto utilizzata anche nelle Marche e in Umbria. Secondo la tradizione toscana, la pastella a base di acqua, farina e sale (alle volte anche farina di castagne) deve essere cotta nel grasso della cotenna del maiale, ma oggi in molti preferiscono utilizzare l’extravergine o lo strutto. Una volta pronti, i testaroli vengono lessati in acqua come una normale pasta, e poi conditi con condimenti leggeri.
Una pasta ripiena di ricotta e bieta, chiamata così perché nata a Melo, una frazione di Cutigliano, in provincia di Pistoia. Qui, nella Val di Lima, veniva tradizionalmente preparata in occasione delle feste per il santo patrono, San Nicolao, celebrato da sempre a settembre.

Una pasta ripiena di forma quadrata farcita con patate lesse e formaggio locale, cotta in acqua bollente e gustata con i tipici ragù di carne. Presente soprattutto a Prato e nel Mugello, a nord di Firenze, il tortello nasce almeno due secoli fa per via della grande produzione locale di tuberi.
a cura di Michela Becchi
Leggi anche…

© Gambero Rosso SPA 2025
P.lva 06051141007 Codice SDI: RWB54P8 Gambero Rosso registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma
Modifica impostazioni cookie
Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]
Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.
Made with love by Programmatic Advertising Ltd
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati
La più autorevole guida del settore dell’enologia italiana giunge quest’anno alla sua 37sima edizione. Vini d’Italia è il risultato del lavoro di uno straordinario gruppo di degustatori, oltre sessanta, che hanno percorso il Paese in lungo e in largo per selezionare solo i migliori: oltre 25.000 vini recensiti prodotti da 2647 cantine. Indirizzi e contatti, ma anche dimensioni aziendali (ettari vitati e bottiglie prodotte), tipo di viticoltura (convenzionale, biologica, e biodinamica o naturale), informazioni per visitare e acquistare direttamente in azienda, sono solo alcune delle indicazioni che s’intrecciano con le storie dei territori, dei vini, degli stili e dei vignaioli. Ogni etichetta è corredata dall’indicazione del prezzo medio in enoteca, delle fasce di prezzo, e da un giudizio qualitativo che si basa sull’ormai famoso sistema iconografico del Gambero Rosso: da uno fino agli ambiti Tre Bicchieri, simbolo di eccellenza della produzione enologica. che quest’anno sono 498.
No results available
ResetNo results available
Reset