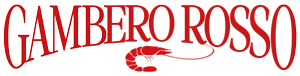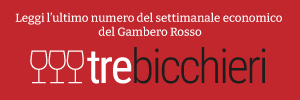Clima
Climate change. Il piano della Francia in 7 mosse
Ne è nata una strategia nazionale per fronteggiare il cambiamento climatico. La tabella di marcia si basa su azioni concrete con interventi previsti anche sui fondi Ocm vino. E l’Italia?
- 05 Gennaio, 2022
- 05/01/22
La Francia si mobilita contro i cambiamenti climatici. E lo fa partendo da una realtà contingente da cui agricoltura e vitivinicoltura non possono ormai prescindere: entro il 2050, l’effetto serra avrà modificato le condizioni di produzione, le caratteristiche organolettiche e i mercati di destinazione dei vini. Discorso che vale a tutte le latitudini ma che i francesi hanno scelto di affrontare con largo anticipo, raccogliendo i frutti prima di altri Paesi. Il Consiglio specializzato sui vini di France Agrimer, il Comitato nazionale dei vini Dop e Igp dell’Inao e l’Istituto francese della vigna e del vino (Ifv) hanno, infatti, completato il lavoro collettivo, avviato nel 2017, per mettere in piedi una strategia nazionale contro il climate change. Il documento è stato presentato ufficialmente a fine agosto, al Ministro francese dell’Agricoltura, Julien Denormandie, ed è basato, a sua volta, sul programma “Laccave”, avviato nel 2012 su iniziativa dell’Inrae (Istituto nazionale per la ricerca agronomica e ambientale) che aveva coinvolto oltre 600 operatori di tutte le aree viticole francesi, tra 2017 e 2019. L’intera filiera transalpina fa, quindi, tesoro di quanto ha imparato in questi ultimi anni, tra vendemmie anticipate, cambiamento nelle caratteristiche dei vini, modifica delle rese in vigneto, per guardare al futuro provando a limitare i danni, nel breve e nel lungo termine. Ne è nata una tabella di marcia, composta complessivamente da 40 azioni (scelte e concertate su un totale di 800 proposte), distribuite in 7 macro ambiti, che vanno da interventi sui metodi di produzione al potenziamento della ricerca, da azioni sulle pratiche enologiche all’uso di materiali vegetali resistenti e adatti alle nuove condizioni ambientali.
Gli effetti sulla viticoltura francese
Lo scenario generale sui cambiamenti climatici è noto. Secondo le previsioni del Gruppo di esperti intergovernativo dell’Onu sull’evoluzione del clima, entro fine XXI secolo assisteremo a un aumento di temperatura tra 2 e 5 gradi Celsius, con conseguente diverso regime di precipitazioni, diverso fabbisogno d’acqua da parte delle colture e incremento degli eventi estremi (ondate di calore e piogge intense). Negli ultimi decenni, gli effetti sulla viticoltura francese sono stati molto chiari: anticipo delle fasi fenologiche (15 giorni nel giro di 26 anni a St. Emilion e Côtes du Rhône; 26 giorni in Alsazia), gradi alcolici più alti, bassa acidità delle uve, modifica dei profili aromatici e polifenolici. E nel lungo elenco di annus horribilis sono finiti il 2003 e il 2006 per il caldo record, la primavera calda e secca del 2011, il gelo del 2012, l’estate piovosa del 2013, l’inverno estremamente (troppo) mite del 2015/16, la siccità del 2019 e le gelate del 2021. La strategia francese, di fronte a uno scenario critico come quello descritto dall’Iea, e di cui si sta occupando la Cop26, la conferenza sul clima delle Nazioni unite in corso a Glasgow, punta a favorire un approccio innovativo che tuteli i vitigni e che eviti lo spostamento dei vigneti in altura o, peggio, una deregulation su metodi e sulle aree di coltivazione della vite.
Migliore conoscenza delle aree viticole
Lavorare alla definizione dei parametri di resistenza e resilienza dei differenti suoli francesi, mediante l’individuazione di specifici indicatori, può essere una soluzione nel segno dell’adattamento della viticoltura alle nuove condizioni. Lo sviluppo della cartografia pedoclimatica (da condividere con le politiche urbanistiche dei Comuni), un più facile accesso al mercato della terra, l’affermazione di una nuova ingegneria del clima sono strumenti concreti che la Francia intende mettere in campo per raggiungere tale obiettivo. La raccolta e la condivisione delle informazioni sarà fondamentale. Pertanto, si parla di mettere in piedi un insieme di stazioni meteo per condividere dati (pioggia, temperatura, umidità) e creare atlanti climatici nazionali e locali che consentano di sviluppare modelli previsionali per le gelate, le ondate di calore, in relazione al loro impatto sul vigneto e sulla maturazione delle uve. Attualmente, uno dei modelli più avanzati è VitiData, piattaforma di informazioni (mista pubblico-privata) condivisa dai viticoltori in Aquitania in funzione di una viticoltura di precisione che accompagni i produttori ad anticipare le strategie di sviluppo e difesa.
Azioni sulle condizioni di produzione
Posto che, nell’ipotesi peggiore, la temperatura in Francia sia destinata entro il 2100 a salire tra 3,4 e 5,3 gradi in media, sarà necessario intervenire su una migliore gestione delle risorse idriche a partire da scelte colturali che limitino la carenza idrica, bypassando l’irrigazione, come la gestione della chioma e l’ombreggiamento (stratégies sèches). Parallelamente, il piano francese prevede la creazione di punti di stoccaggio dell’acqua, con microsbarramenti nelle zone collinari. C’è, nel piano inviato al Ministero, l’importante apertura alla modifica e alla semplificazione delle regole sull’irrigazione, oggi vietata dal 15 agosto fino alla raccolta per le uve da vino e dal primo maggio alla vendemmia (salvo deroghe) per le uve a Dop. Inoltre, anche l’attività di ricerca e sviluppo dovrà essere orientata a definire gli effetti dei cambiamenti climatici sulle pratiche colturali, sulle caratteristiche analitiche e sensoriali, per consentire alle imprese di fare scelte adeguate rispetto al tipo di coltivazione. Va da sé che i disciplinari dei vini di qualità dovranno adeguarsi.
Promuovere materiali vegetali adeguati
Alla base della coltivazione della vite c’è la scelta del materiale vegetale. Operazione considerata fondamentale nel piano francese sui cambiamenti climatici in viticoltura, che contempla aiuti economici tramite le misure innovazione e investimenti dell’Ocm vino alle imprese che intendono sperimentare nuovi vitigni o che devono estirpare quelli testati con esito negativo; allo stesso tempo, anche le fasi di ristrutturazione dei vigneti dovranno favorire colture più adatte ai cambiamenti climatici. Alla base, ci sarà da mettere mano alle regole, alle procedure e ai tempi per l’ingresso di determinate varietà nel Catalogo nazionale delle viti, detenuto presso il Ministero dell’Agricoltura. Si guarda, in particolare, alle cosiddette Vifa (varietà d’interesse per l’adattamento) che, prima di essere approvate, oggi vengono testate per un minimo di dieci anni, limitate a 10 varietà per Dop e coltivate dalle imprese per un massimo del 5% della superficie totale.
Le pratiche enologiche per contenere il titolo alcolometrico
Mosti più ricchi di zucchero e vini con maggiore titolo alcolometrico. L’effetto del climate change in cantina è evidente, ma le pratiche enologiche (basate sul regolamento Ue 934/2019) possono limitare i danni. Senza stravolgere la definizione di vino, e tenendo valide le regole definite dal Codice Oiv delle pratiche enologiche, la Francia mette sul tavolo la possibilità di dealcolare i prodotti vitivinicoli al di là di quanto previsto dalle leggi attuali, che prevedono un limite del 20% alla riduzione del tenore alcolico del prodotto. Il nodo è proprio questa percentuale, che la filiera transalpina – come si può leggere nel piano presentato alle istituzioni – vorrebbe superare, considerato il forte incremento del tenore alcolico dovuto ai cambiamenti climatici, che ovviamente determina un disequilibrio nei vini.
Altro nodo è l’acidificazione dei mosti, che rimedia all’insufficienza di acidità naturale provocata dall’eccesso di calore in vigneto e a una non corretta maturazione delle uve. La Francia, nel suo piano, considera necessario applicare più flessibilità alle regole europee in materia.
Evoluzione dei mercati e intelligenza artificiale
È indubbio che tra le conseguenze del climate change ci sia un aumento della variabilità della quantità di vino prodotto, così come della qualità. Pertanto, la filiera francese considera indispensabile che le imprese adottino strategie difensive. La prima è una nuova organizzazione del lavoro, che eviti l’esposizione degli operai al sole nelle ore calde, che preveda equipaggiamenti di protezione individuale, il lavoro notturno, l’introduzione della robotica nei vigneti e l’intelligenza artificiale.
Altra operazione importante è vincolare gli aiuti Ocm alla stipula di contratti d’assicurazione multirischio contro il clima, ma anche favorire la mutua assistenza tra i viticoltori in caso di calamità naturali, modificando i regolamenti per far sì che il viticoltore non danneggiato possa aumentare le rese e fornire uve al vicino che le ha perse. Infine, si prevede un sostegno finanziario per l’installazione di dispositivi anti-gelo, anti-grandine o per ridurre l’impatto della siccità.
Ricerca, sviluppo, formazione: una road map
Il mondo della ricerca scientifica dovrà viaggiare con in tasca una road map che le consenta di sostenere il settore vitivinicolo in questa sfida. La Francia, in particolare, pensa a progetti di ricerca partecipativi che coinvolgano imprese, consumatori, enti pubblici e territoriali. Gli sforzi per il comparto ricerca e sviluppo dovrebbero portare creare un Piano climatico per la filiera del vino sul modello del Piano nazionale sull’impoverimento del vigneto. Nel concreto, la filiera vino chiede che il cambiamento climatico sia inserito come primo criterio prioritario nei bandi per progetti a valere sui fondi Casdar sull’innovazione e lo sviluppo rurale, finanziati dalle stesse imprese in percentuale sui ricavi annui, tramite le Camere dell’agricoltura. Le istituzioni già si muovono. Inrae e Ifv hanno rinnovato la partnership decennale che ha come scopo l’adattamento dei vigneti al climate change, basandosi sulla rete Inrae (programma Laccave 2.21) e anche la rete delle Camere agricoltura e degli Istituti agrari è attiva, tramite un contratto obiettivo, assieme al Ministero dell’Agricoltura per migliorare la capacità di adattamento dei sistemi agricoli.
Attenuare l’impatto ambientale riducendo la Co2
La riduzione dei gas a effetto serra è tra i compiti della filiera vino francese che, nel suo piano nazionale, pone tra gli obiettivi il cosiddetto sequestro del carbonio nel sottosuolo, in funzione di un minor impatto ambientale. Per raggiungere questi obiettivi, lo sviluppo di indicatori di impronta carbonica è fondamentale. L’identificazione delle pratiche maggiormente impattanti sul clima (a livello di filiera, regione viticola, singola impresa) va accompagnata a obiettivi di riduzione della Co2 nel breve termine, ovvero cinque anni. Il calcolo dell’uso dell’acqua (impronta idrica) è tra le azioni complementari. Questo attiverebbe una serie di agevolazioni e incentivi, previsti nel marchio “low carbon”, previsti dal Ministero per la Transizione ecologica. Si tratta non tanto un’etichetta di prodotto quanto di progetto che consentirebbe, ad esempio, a un gruppo di viticoltori impegnati in pratiche di riduzione dei gas serra, di ottenere il marchio dello Stato e, pertanto, di accedere a crediti e agevolazioni sul cosiddetto mercato del carbonio, che premia i progetti virtuosi per clima e ambiente, offrendo una sorta di certificazione verde per attirare potenziali finanziatori. L’Inrae, attraverso l’iniziativa “4 per 1000”, sta già promuovendo le pratiche sostenibili che favoriscono la captazione del carbonio nel sottosuolo: dal contributo della materia organica all’uso del sovescio, dall’inerbimento dei filari alla cura dei perimetri dei vigneti, a partire da siepi e fosse. Tra le proposte, c’è quella di valutare quella di evitare l’aratura dei suoli. Sul fronte tecnologico, anche le macchine agricole dovranno ridurre il consumo di carburanti fossili. Lo si potrà fare, secondo il piano della filiera vino francese, favorendo i motori elettrici e la robotica, come sta avvenendo ora con la rete di imprese sperimentali appartenenti al marchio Digifermes. Allo stesso tempo, facendo formazione e sensibilizzazione tra i viticoltori e misurando l’impronta carbonica dei diserbi meccanici.
Risparmio energetico e fondi Ocm
Da un punto di vista strutturale, l’esigenza più sentita è favorire gli investimenti per il rinnovo o la costruzione di edifici coibentati, a basso consumo energetico e idrico, alimentati col solare. Un supporto agli uffici di architettura e di progettazione potrebbe arrivare anche dall’istituzione di corsi di formazione specifici in bioedilizia. Imprese e istituzioni francesi stanno riflettendo se intervenire sull’Ocm vino: “La misura investimenti” si legge nel piano “dovrebbe essere utilizzata per finanziare solamente edifici eco-sostenibili”. Le cantine, infine, dovranno modificare le pratiche quotidiane: dall’installazione di pannelli fotovoltaici e contatori ad hoc, all’uso di bottiglie più leggere, materiali ecologici, tappi naturali e cartone fino alla progettazione di sistemi di confezionamento a basso impatto carbonico. Ad esempio, la distribuzione di vini al bicchiere in contenitori ecologici adatti al circuito Horeca, l’uso di fusti (come quelli prodotti dalla francese Ecofass) fino ai bag in box.
La Francia del futuro
Quaranta azioni concrete contro il cambiamento climatico, quindi, destinate a modificare l’approccio della Francia che – ancora una volta, come spesso accade – vuole anticipare i tempi d’azione, confermandosi all’avanguardia precorrendo le tendenze, a cominciare dal settore vitivinicolo. L’Italia, dal canto suo, sta per definire, attraverso il Mipaaf, il proprio protocollo di sostenibilità nazionale in viticoltura, mediante decreti applicativi (LINK Articolo Loredana su tre bicchieri). Anche qui, l’eterna partita tra i due grandi leader mondiali si annuncia particolarmente agguerrita.
Sono 40 le azioni urgenti in 7 ambiti
- migliorare la conoscenza delle zone viticole
- intervenire sui metodi di produzione
- favorire materiale vegetale resistente
- agire sulle pratiche enologiche
- monitorare i mercati e proteggere le produzioni
- rafforzare ricerca, sviluppo e formazione
- ridurre le emissioni inquinanti
a cura di Gianluca Atzeni
Corsi per Appassionati
Corsi per Professionisti

University
Master
© Gambero Rosso SPA 2025
P.lva 06051141007 Codice SDI: RWB54P8 Gambero Rosso registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma
Modifica impostazioni cookie
Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: dpo@class.it
Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.
Made with love by Programmatic Advertising Ltd
Made with love by Programmatic Advertising Ltd
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati