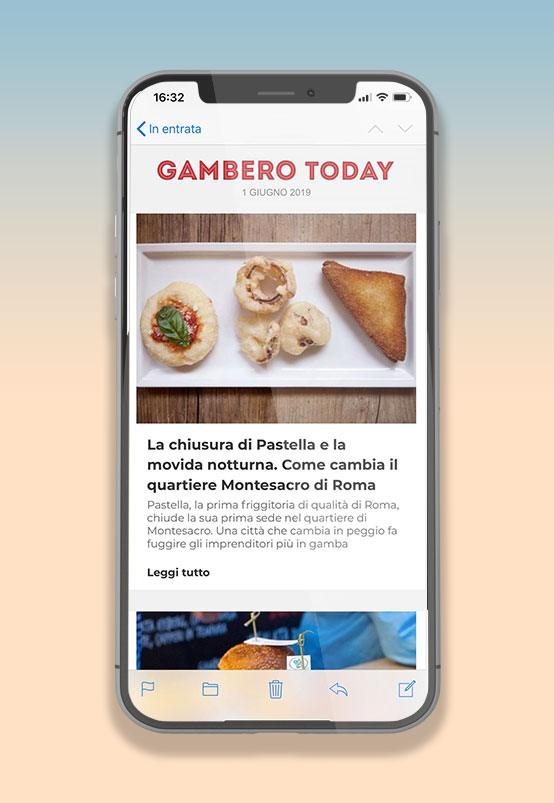C’è un termine francese, jacquerie, che anche se oggi non è di uso comune, a un certo punto è entrato nel nostro vocabolario e ci è rimasto. È una parola che si porta dietro un discreto fascino, non tanto perché alle sue spalle si muove una brulicante aneddotica (non è vero: anche e forse in buona parte per questo), quanto perché, come altre parole sue simili, è poco comune ma ha avuto uno straordinario successo, ha travalicato epoche e luoghi, e si porta appresso tutta una serie di illuminanti spiegazioni sul nostro passato e sul nostro presente. In senso ampio, con jacquerie si intende l’insurrezione popolare non organizzata: originariamente il termine indicava nello specifico l’insurrezione antifeudale dei contadini (e ancora più nello specifico la rivolta deflagrata nell’Oise nel 1358), che in Francia venivano chiamati dalla nobiltà con il nome sprezzante di «Jacques Bonhomme», che noi tradurremmo in italiano con Giacomo Ometto.
Per chi ha natali piemontesi il senso di Bonhomme è molto più chiaro e intuitivo di quanto tradisca questo adattamento: bonòm (si legge bunom) in dialetto identifica una persona un po’ ingenua e sottomessa, uno che vale poco per mancanza di personalità. È un termine derisorio che in sé contiene ed esprime tutto lo sdegno nobiliare rivolto nel Medioevo alla gente che abitava le campagne, che si nutriva del senso di superiorità delle classi dominanti. Il Trecento fu a tal punto un secolo di rivolte popolari e contadine che Jacques Bonhomme e (soprattutto) la jacquerie divennero un simbolo archetipico, capace di resistere intatto nei secoli.
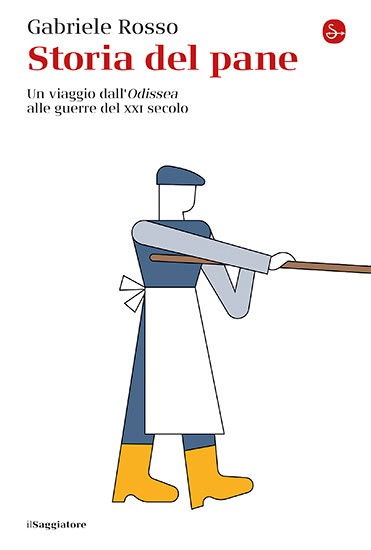
L’insurrezione popolare del Trecento
L’episodio circoscritto che diede i natali alla jacquerie, la Jacquerie con la J maiuscola, fu quello, come accennato, che nel 1358 vide i contadini dell’Oise, regione situata appena a nord di Parigi, ribellarsi alla crisi economica e politica figlia della Guerra dei cent’anni. Anche se i contadini furono sconfitti e i moti repressi nel sangue, con migliaia di vittime rimaste a terra, resta il fatto che il Trecento fu, in tutto e per tutto, il secolo delle grandi crisi e quindi delle grandi rivolte, non solo in Francia: abbiamo già accennato che alla Grande carestia del 1315-1317 aveva fatto seguito la peste nera del 1347-1350, e a ciò si erano aggiunte le frequentissime guerre con le loro razzie. Le sfide poste al mondo contadino dalla sostituzione delle colture cerealicole con produzioni più redditizie (per i padroni) e dalle prepotenze del ceto fondiario – quasi sempre identificabile con il nobile-feudatario di turno – divennero la benzina che accese lo scontro.
Visto il contesto, e visto il valore materiale e culturale assurto dal pane nel corso dell’epoca medievale, non deve stupire il fatto che la parola d’ordine delle rivolte trecentesche fosse «le pain se lève»: un gioco di parole tra «il pane lievita» e «il pane si solleva» (nel senso di ribellione) che divenne «the bread will raise» in Inghilterra, dove a guidare le sollevazioni nel 1381 furono Wat Tyler e il prete e fervente oppositore del feudalesimo John Ball. Costoro furono alla guida di una rivolta contadina che mise a ferro e fuoco prima Canterbury (con tanto di decapitazione dell’arcivescovo) e poi Blackheath, per poi marciare su Londra. Al re Riccardo II, allora appena quattordicenne, Tyler chiese l’abolizione della servitù feudale, il diritto di macinare il grano e di cuocere il pane, così come quello di farsi la birra. Questo perché il sistema feudale, nel suo continuo moltiplicare le imposizioni e i balzelli di cui si nutriva il parassitismo nobiliare, impediva praticamente ai contadini di panificare a casa, obbligandoli a servirsi dei forni del signore, con tanto di tassa a fare da esoso contorno. Ovviamente anche questa rivolta fu soffocata nel sangue, e il diritto di macinare il grano e di cuocere il pane rimase precluso ai contadini inglesi.
L’assalto ai forni manzoniano
Se il Medioevo, dunque, collocò il pane al centro della ribellione politica delle classi più svantaggiate, fu tuttavia l’età moderna, quella che per convenzione è compresa tra la scoperta dell’America nel 1492 e la Rivoluzione francese nel 1789, a cucirgli intorno un portamento movimentista, a issarlo sulle barricate e a coltivarne il potere simbolico di rivendicazione sociale. Uno degli elementi più interessanti di questa vicenda culturale è però in un certo senso testimoniato per via indiretta, essendo riportato in un romanzo (per quanto costruito intorno a eventi storici realmente accaduti) ambientato nel 1628, ma scritto quasi due secoli dopo e pubblicato nella sua prima edizione tra il 1825 e il 1827: mi riferisco all’episodio del XII capitolo de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, che racconta l’assalto al forno delle grucce durante il tumulto di San Martino, in quel di Milano.
Sull’indole politica di Alessandro Manzoni si è scritto tutto e il contrario di tutto, dipingendo questo padre della letteratura italiana di volta in volta come rivoluzionario, impenitente conservatore, censore del clericalismo, cattolico bigotto, a seconda degli scritti che l’interprete di turno citava, provenienti da varie fasi della sua carriera. Qui, a ogni modo, ci concentreremo solo in modo circoscritto sul senso politico del pane nel romanzo.

Il celebre assalto al forno delle grucce – episodio storico realmente accaduto – nel racconto manzoniano viene mostrato come il risultato del cortocircuito tra una condizione di natura ambientale e una decisione di umanissima impronta: il 1628, l’anno in cui sono ambientate le vicende del romanzo, fu il secondo consecutivo di scarsi raccolti a causa del clima e delle guerre, situazione questa aggravata dal fatto che le scorte erano già state intaccate nei mesi precedenti. La risposta «amministrativa» per mano del gran cancelliere Antonio Ferrer, che faceva le veci di don Gonzalo Fernández de Córdoba, impegnato nell’assedio di Casale Monferrato, fu di fissare il prezzo del pane per decreto, senza tenere conto del fatto che la farina aveva raggiunto un prezzo molto alto, e che quindi fare pane a quelle condizioni non era economicamente sostenibile per i fornai. Messi alle strette, questi ultimi ottennero infine l’aumento del prezzo del pane: «I fornai respirarono; ma il popolo imbestialì».
Del Manzoni è ammirevole la capacità, nel contesto del romanzo storico, di colorare la narrazione con pennellate di pathos e dettagli davvero efficaci. Nelle pagine che raccontano l’episodio gli esempi sarebbero innumerevoli, a partire dalla descrizione delle «moltitudini», quelle masse popolari che sarebbero diventate nel secolo in cui Manzoni viveva e scriveva protagoniste indiscusse della dialettica pubblica e dei sollevamenti sociali, e che egli riconosce già in azione due secoli prima:
Gl’incettatori di grano, reali o immaginari, i possessori di terre, che non lo vendevano tutto in un giorno, i fornai che ne compravano, tutti coloro in somma che ne avessero o poco o assai, o che avessero il nome d’averne, a questi si dava la colpa della penuria e del rincaro, questi erano il bersaglio del lamento universale, l’abbominio della moltitudine male e ben vestita. Si diceva di sicuro dov’erano i magazzini, i granai, colmi, traboccanti, appuntellati; s’in- dicava il numero de’ sacchi, spropositato; si parlava con certezza dell’immensa quantità di granaglie che veniva spedita segretamente in altri paesi; ne’ quali probabilmente si gridava, con altrettanta sicurezza e con fremito uguale, che le granaglie di là venivano a Milano.

La psicologia delle masse, branca della psicologia sociale sviluppatasi nel secondo Ottocento sulla scia dell’impatto della Rivoluzione francese, dei moti del 1848 e della Comune di Parigi del 1870, trovò negli studi di due intellettuali borghesi come Gustave Le Bon e Gabriel Tarde – ai ferri corti con il clima di perenne disordine politico dell’epoca – i suoi alfieri più celebri e (giustamente) celebrati. Tuttavia, l’affresco di Manzoni coglieva nel segno già molti anni prima: «La sera avanti questo giorno in cui Renzo arrivò in Milano, le strade e le piazze brulicavano d’uomini, che trasportati da una rabbia comune, predominati da un pensiero comune, conoscenti o estranei, si riunivano in crocchi, senza essersi dati l’intesa, quasi senza avvedersene, come gocciole sparse sullo stesso pendío». E ancora: «Migliaia d’uomini andarono a letto col sentimento indeterminato che qualche cosa bisognava fare, che qualche cosa si farebbe».
L'insurrezione a Milano
Le strade di Milano ribollivano di fame e di rabbia, e alcuni cominciarono a depredare i garzoni che consegnavano il pane a chi se lo poteva permettere, finché si udì gridare «al forno! al forno!». La folla ormai innescata di- ventò un fiume in piena, e si diresse in strada Corsia de’ Servi dove si trovava il forno delle grucce. Qui l’assalto fu veloce, incontrollabile: non bastarono le porte e le finestre serrate, non bastarono il capitano di giustizia e gli alabardieri intervenuti: «La gente comincia ad affollarsi di fuori, e a gridare: – pane! pane! aprite! aprite!». Una volta dentro, si delinea il momento di più furiosa irrazionalità della folla:
La vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose. Si slanciano ai cassoni; il pane è messo a ruba. Qualcheduno in vece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia a manate, intasca, ed esce carico di quattrini, per tornar poi a rubar pane, se ne rimarrà. La folla si sparge ne’ magazzini. Metton mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano: chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca, e, per ridurlo a un carico da potersi portare, butta via una parte della farina: chi, gridando: – aspetta, aspetta, – si china a parare il grembiule, un fazzoletto, il cappello, per ricever quella grazia di Dio; uno corre a una madia, e prende un pezzo di pasta, che s’allunga, e gli scappa da ogni parte; un altro, che ha conquistato un burattello, lo porta per aria: chi va, chi viene: uomini, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli, e un bianco polverío che per tutto si posa, per tutto si solleva, e tutto vela e annebbia. Di fuori, una calca composta di due processioni opposte, che si rompono e s’intralciano a vicenda, di chi esce con la preda, e di chi vuol entrare a farne.
Sembra di stare di fronte a un quadro coloratissimo, talmente è vivida la descrizione. La folla milanese seicentesca dipinta da Manzoni ha gli stessi tratti che Le Bon vedeva nelle folle ottocentesche, e su cui aveva costruito la tesi al centro del fortunato pamphlet Psychologie des foules, uscito nel 1895: tratti tutti in negativo, a scanso di equivoci. Nella folla, sosteneva infatti Le Bon, l’individuo muta psicologicamente e in modo radicale, compiendo azioni che da solo non avrebbe mai compiuto, lasciandosi trascinare da impulsività e violenza. Sono tre, a suo dire, i meccanismi fondamentali che caratterizzano l’individuo immerso nella folla: l’acquisizione di un senso di potenza invincibile; l’agire per suggestione; e la trasmissione di quest’ultima da un individuo all’altro per contagio, come se fosse una malattia infettiva. La folla milanese de I promessi sposi è agitata dalle stesse dinamiche, potremmo dire. Renzo, il protagonista maschile del romanzo, no: vi si intrufola sospettoso, osserva, se ne sta in disparte e tra sé e sé biasima i riottosi. In questo suo «posizionamento» possiamo leggere tutta la presa di distanza manzoniana dalle folle cittadine e dai disordini, pur restando I promessi sposi un romanzo delle classi subalterne, e di denuncia dell’autoritarismo del potere.
*Estratto del libro Storia del pane - Un viaggio dall'Odissea alle guerre del XXI secolo pubblicato da Il Saggiatore