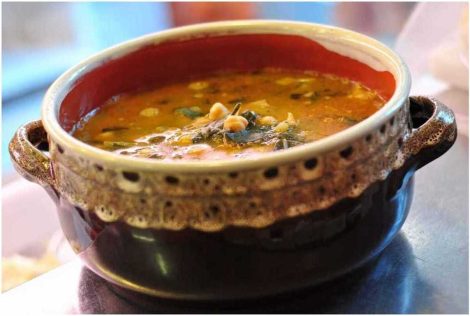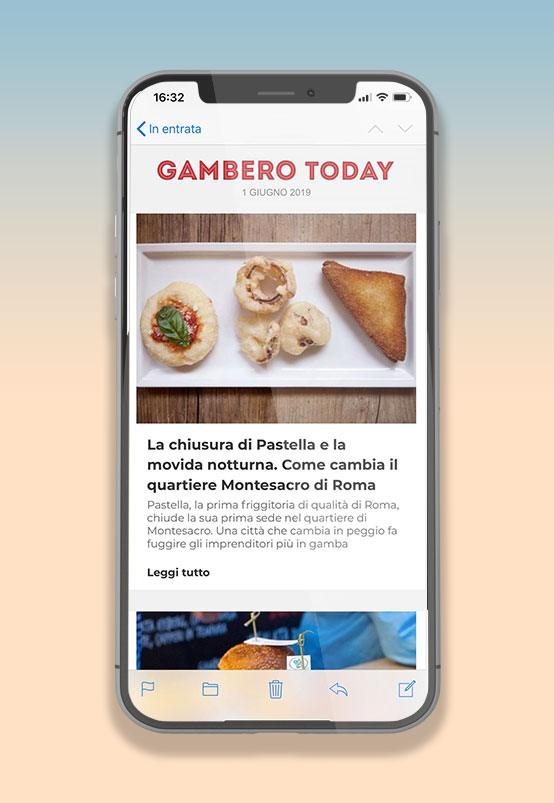«C'è bisogno di più monitoraggio e meno inquinamento chimico». Non usa giri di parole la commissaria europea per l'ambiente Jessika Roswall quando si riferisce all'Italia in occasione della conferenza stampa per la presentazione dei rapporti sullo stato delle acque nell'Unione Europea. Un problema, quello delle risorse idriche che sarà destinato a cambiare la faccia del Vecchio Continente nei prossimi 100 anni a causa dell'aumento di siccità, inondazioni, desertificazione e del loro impatto devastante e che oggi conta meno del 40% dei corpi idrici superficiali con un buono stato ecologico. E se il 74% della Spagna risulta a rischio reale di desertificazione, il Belpaese non se la passa meglio, soprattutto per quanto riguarda la qualità e la gestione delle nostre risorse idriche. Dal 2018 l'Italia soffre di estati sempre più secche e calde, e negli ultimi anni questi problemi, già più noti nella parte meridionale del Paese, sono diventati un problema ricorrente anche nella parte settentrionale del Paese. L'Italia è considerata sempre più vulnerabile a gravi alluvioni, che hanno colpito regolarmente il Paese nell'ultimo decennio.

Il problema delle risorse idriche superficiali in Italia
Inquinamento industriale e agricolo, estrazioni, gestione delle acque reflue urbane, carenza idrica: i problemi dell'Italia si articolano su più fronti. In primis il report dedicato a noi mette in luce come siamo sempre più di carenza idrica: nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, l'indice di sfruttamento idrico Wei+ (Water Exploitation Index Plus) dell'Italia è stato compreso tra il 7,3% e il 14,7%. Questi valori sono inferiori al 20%, che è generalmente considerato un'indicazione di scarsità d'acqua, ma è importante sottolineare che l'Italia è caratterizzata da grandi cambiamenti stagionali e geografici. Nel 2019, ad esempio, l'indice nazionale Wei+ ha superato il 44% tra luglio e settembre, segnalando gravi problemi di carenza idrica in estate a livello nazionale. Anche per quanto riguarda le acque superficiali le differenze sono notevoli, con l'indice Wei+ della Sicilia che ha raggiunto un picco del 93,5% durante l'estate 2019. Oltre al rischio siccità, le principali pressioni sui corpi idrici superficiali italiani sono relative all'inquinamento diffuso causato dalle attività agricole, dall'inquinamento da acque reflue urbane e dalle alterazioni idromorfologiche. L'inquinamento diffuso da parte dell'agricoltura è una problematica che riguarda oltre un terzo dei corpi idrici superficiali, mentre l'inquinamento da acque reflue urbane è al secondo posto e interessa un quarto delle acque superficiali. In particolare, per quanto riguarda proprio quest'ultimo aspetto l'Italia è in ritardo rispetto alla media Ue nell'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane in quanto agisce solo sul 56% di queste.
Lo stato delle falde acquifere
Circa il 77% dei corpi idrici sotterranei in cattivo stato quantitativo sono interessati da significative
pressioni di estrazione da parte dell'approvvigionamento idrico pubblico, dell'industria, dell'agricoltura, degli allevamenti ittici, dell'energia idroelettrica, dell'acqua di raffreddamento e di altri settori, nonché da alterazioni del livello o del volume delle acque sotterranee. Il restante 23% dei corpi idrici sotterranei in cattivo stato quantitativo rappresenta acquiferi sovrasfruttati, dove l'estrazione dell'acqua costituiva una pressione significativa in passato, ma che ora stanno attraversando una lenta fase di recupero. Inoltre, circa tre quarti delle falde che rischiano di non raggiungere un buono stato quantitativo entro il 2027, sono interessate da estrazioni.

L'inquinamento delle acque nostrane
L'inquinamento chimico, dovuto alla presenza di tossine persistenti e bioaccumulabili onnipresenti e alle emissioni industriali (tra cui metalli pesanti, Pfos, ritardanti di fiamma), rimane una sfida, anche se sono stati registrati alcuni miglioramenti nello stato chimico delle acque. Le sostanze che causano la più alta percentuale di sforamento degli obiettivi sono quelle persistenti, bioaccumulabili e tossiche che sono per lo più introdotte nelle acque superficiali attraverso la deposizione atmosferica, in particolare mercurio e Ipa (idrocarburi policiclici aromatici). Sostanze che sono solitamente rilasciate durante i processi di combustione dei combustibili fossili.
Come sta facendo l'Italia per ridurre l'inquinamento idrico dall'agricoltura
Nel Piano Strategico della PAC (2023-2027) l'Italia prevede di aumentare il sostegno agli agricoltori per il mantenimento e la conversione all'agricoltura biologica dall'attuale 18% al 25% della superficie agricola entro il 2027. Nei suoi piani di sviluppo rurale, l'Italia ha previsto anche diversi interventi agro-climatico-ambientali, tra cui una serie di misure incentrate sulla gestione sostenibile dei nutrienti per le acque superficiali nonché misure per il trattamento dei carichi inquinanti negli effluenti degli allevamenti utilizzando il fito-trattamento. Infine, l'Italia include anche nei suoi Piani di Gestione dei Bacini idrografici misure di protezione dell'acqua potabile, le più rilevanti delle quali riguardano la definizione e la gestione delle acque reflue.