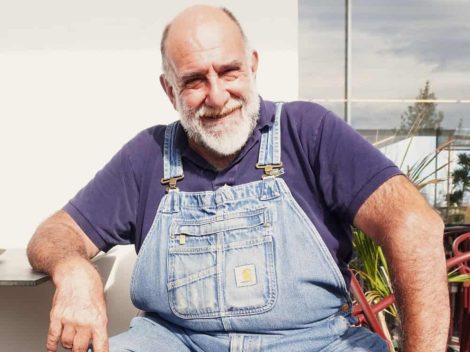Non sappiamo se Hirayama sia un uomo felice. Anzi di lui non sappiamo quasi niente, se non tutti i dettagli della sua quotidianità. Il protagonista di Perfect Days, il film di Wim Wenders, presentato al Festival di Cannes e candidato come miglior film straniero agli Oscar 2024, è in uomo dedito alla ritualità. Ogni mattina si alza prima del sole senza bisogno della sveglia, piega il suo futon, accorcia baffi e barba, innaffia le piantine, indossa l’uniforme della Tokyo Toilet, prende un caffè in lattina e con il suo furgone va lavoro. Un lavoro molto umile – addetto alle pulizie dei bagni pubblici della città – verso cui, però, mostra tutta la dedizione di chi ama quello che fa sopra ogni altra cosa. Nel preciso momento in cui l’alba esplode in cielo, Hirayama (magistralmente interpretato da Koji Yakuso) fa esplodere la musica rigorosamente americana e rigorosamente incisa su musicassette: The Animals, Patti Smith, Van Morrison, Nina Simone e ovviamente Lou Reed (è la sua Perfect Days a dare il titolo alla pellicola).
L’usanza di bere caffè in lattina
Nella ripetitività quasi maniacale dei gesti, va da sé, rientra anche la ritualità dei pasti. Sempre gli stessi, sempre negli stessi posti e con la stessa cadenza. In questa poesia del quotidiano, una piccola incursione nella cultura gastronomica giapponese. Si inizia la mattina, con caffè in lattina, preso direttamente dal distributore di fronte casa. Un piccolo gesto che ci mostra un trend molto diffuso: sono migliaia i distributori automatici di lattine, disseminati in ogni angolo del Sol Levante. D’altronde, il primo caffè al mondo in lattina è proprio un’invenzione giapponese che risale al 1969, venduto dalla UCC Ueshima Coffee Co nella versione calda o fredda.
La rassicurante sequenza dei pasti: shochu, yakisoba e banshaku
Per pranzo il menu prevede tramezzini (altra influenza americana, oltre alla musica) consumati su una panchina del parco, mentre Hirayama cerca di catturare con la sua fotocamera analogica la luce che filtra tra gli alberi, secondo il principio del komorebi (spoiler: non alzatevi durante i titoli di coda per afferrare bene il concetto, se non addirittura tutto il senso del film).
Finito di lavorare, è il proprietario di un fast food nipponico, ad accoglierlo ogni sera con la stessa formula di cortesia – “Alla tua salute dopo una faticosa giornata” – un sorriso e un bicchiere di shochu (distillato di riso) con soda e ghiaccio. Per poi servirgli yakisoba, gli spaghetti alla giapponese cotti a vapore e poi piastrati con cavolo cappuccio, carne di maiale e alga nori. E il giorno dopo si ricomincia sempre con lo stesso rassicurante ordine: caffè-tramezzino-sohochu-yakisoba, in una sequenza che quasi invita lo spettatore-voyeur ad anticipare le azioni nella propria memoria.
Fino a quando non arriva la domenica, giornata di riposo, in cui ogni azione cambia. A partire dal luogo di ristoro: non più il fast food, ma il ristorante in cui tutto è più lento e ci si può permettere anche di fermarsi ad ascoltare la proprietaria cantare. Qui, nel ristorante della signora Mama la cena è a base di insalata di patate, cipolla e prosciutto cotto con maionese. Una sorta di banshaku che di solito si accompagna all’alcol. “Ban” infatti, sta per sera, mentre shaku significa letteralmente “bere a casa con pasto serale”. In pratica un sostituto della cena. Un piccolo diversivo prima di ricominciare la settimana e la routine.
Il cibo come ritualità
A saper guardare, però, la routine di Hirayama è anche piena di sfumature e piccoli “incidenti” di percorso che modificano la perfezione della sequenza e rendono ogni giorno diverso dall’altro: un turno di lavoro di troppo, una cena improvvisata a casa, l’arrivo di una nipote persa di vista, l’incursione in un negozio di dischi usati, una partita a tris con un avversario invisibile o una serata a rincorrere la propria ombra con uno sconosciuto. Una variazione del concetto di wabi-sabi orientale: la bellezza imperfetta delle cose.
Perfect Days è una storia senza storia, un film per sottrazione, una poesia senza troppe parole. Anche il cibo a prima vista potrebbe non sembrare preponderante, ma in questa quotidianità sussurrata è uno di quegli elementi che finisce, con la sua ripetitività, per dare ritmo alla narrazione. D’Altronde non è forse il cibo a scadenzare la quotidianità di ognuno di noi in un rituale che si ripete di giorno in giorno e che ci riporta a quel “qui e adesso” tanto caro al protagonista?