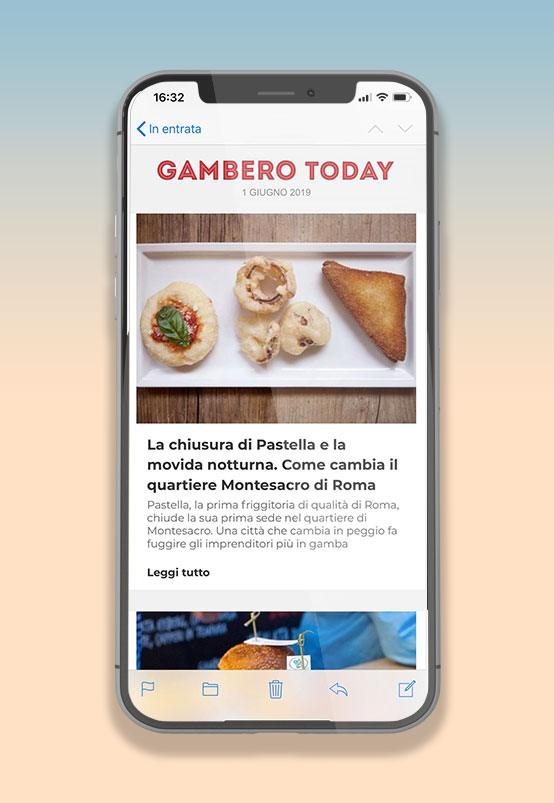«Il vino è come una bustina di tè, che si immerge in un brodo culturale più ampio, un concetto che possiamo riassumere nella parola terroir: un territorio abitato da comunità umane che, nel corso della loro storia, hanno costruito una sensibilità estetica, scegliendo di caratterizzare i loro prodotti in modi che risultano spesso coerenti, riconoscibili e, alla fine, rappresentativi di quelle terre e di quelle persone. Questa scintilla culturale, questa visione del vino come parte di un contesto più ampio, la dobbiamo a Luigi Veronelli». Armando Castagno è una delle voci più autorevoli nel panorama enoico italiano, ha appena firmato il brillante Viaggio in Franciacorta, edito da Treccani. Gli abbiamo chiesto di raccontarci l’evoluzione della comunicazione del vino, tra linguaggi, tendenze e prospettive future alla luce della sua ventennale carriera di critico, scrittore e divulgatore.
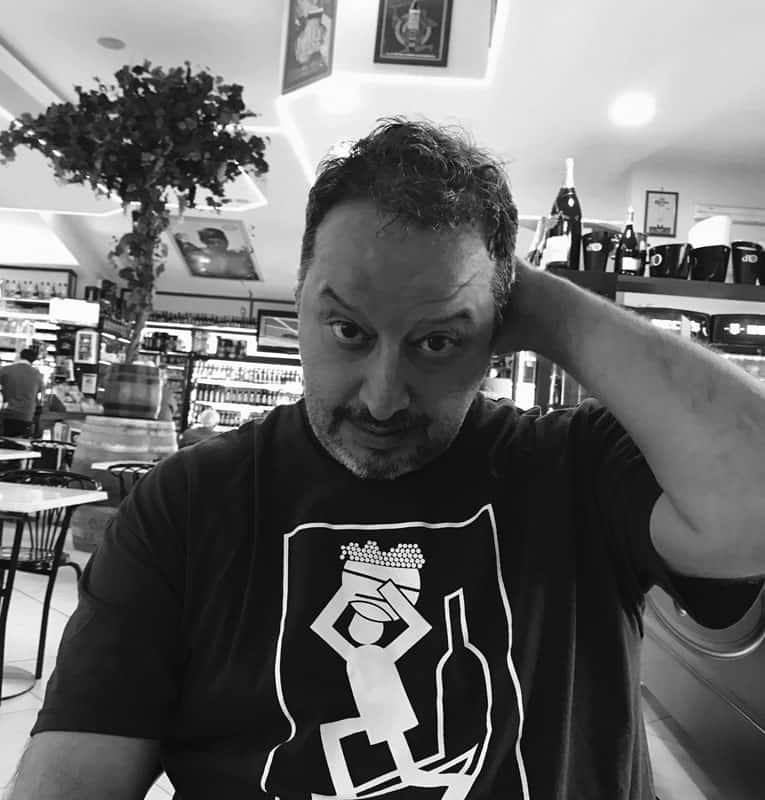
Armando Castagno
Com’è cambiato il modo di raccontare il vino da quando ha iniziato il suo impegno sul campo?
È cambiato moltissimo in questi 23 anni. All'epoca c'erano ancora gli ultimi lacerti di una comunicazione molto specialistica dominate dalle convenzioni e dai protocolli comunicativi delle associazioni di sommellerie, con un linguaggio molto più autoreferenziale sul quale non avevano avuto un peso così importante, forse per l'inimitabilità dei soggetti ispiratori, le scorribande linguistiche di Veronelli o le connessioni culturali di Soldati o di Monelli. C’era una comunicazione stantia da almeno venti o trent'anni. Mentre altrove nel mondo era già iniziata questa parabola che ha portato la comunicazione a diventare prosaica, letteraria, sintetica, persino fino a eccessi come i punteggi centesimali attribuiti senza spiegazioni ulteriori.
E poi?
Forse per una reazione endogena del sistema, e senza un nesso evidente tra i vari fenomeni, sono emersi nuovi ambiti di comunicazione del vino, come alcune riviste e forum, tra cui quelli del Gambero Rosso che considero in Italia di primaria importanza: una vera incubatrice. In questi spazi, la comunicazione ha iniziato a diventare più colloquiale, introducendo una divulgazione basata su termini intelligibili, assorbiti progressivamente dalla lingua parlata. Questo ha portato a una sorta di “volgarizzazione tecnica” del linguaggio del vino che ha contribuito a una sua popolarizzazione, estendendosi anche al mondo del beverage. Da qui sono derivati fenomeni come il boom del bio, del vino naturale, delle birre artigianali e la crescente diffidenza verso l'enologia additiva e verso l'enologia in generale, un'estremizzazione di questa tendenza. Ma tutto va nella stessa direzione: la disperata ricerca di genuinità. Anche la lingua si è adeguata.

Il linguaggio della critica enologica è sempre percepito come molto tecnico, a volte criptico, complesso…
La peggiore critica enologica continua ad avere, come anche il peggiore giornalismo, un istinto di autoconservazione molto forte e quindi una refrattarietà al nuovo che definirei proprio statutaria, congenita. L’elemento del settarismo sembra ineliminabile e porta ovviamente all'adozione di linguaggi inattingibili dagli altri e quindi all’autopromozione di grandi esperti. Ma questo vale in tutti i settori.
Semplificarlo banalizzerebbe la materia? La precisione terminologica è davvero così irrinunciabile in alcuni aspetti del racconto del vino?
È ovvio che in un consesso di enologi o di agronomi, se si parla di tecniche di lotta all'eccesso di quercetina o alla Drosophila Suzukii bisogna essere precisi. Nella comunicazione del vino, dal punto di vista della critica, erogata nei confronti di un pubblico che ha curiosità ma non ha una preparazione tecnica, usare un linguaggio semplice non è banalizzare la materia perché il vino non è banale di suo. In qualunque settore si tocchi la sfera culturale noi abbiamo assistito a una semplificazione dei mezzi espressivi. La conquista della semplicità è nella storia di tantissimi artisti di tutti gli ambiti, dalla musica all'arte.

Con l’aumento dei contenuti social, la critica del vino può ancora mediare tra produttore e consumatore o rischia di diventare marginale?
Critica è una parola bellissima, che deriva dal greco krínein, che significa giudicare. Il suo significato originario era legato all'agricoltura: indicava la separazione del grano dalle erbe infestanti. E se vogliamo, questa metafora regge ancora: a patto che la critica venga esercitata nell'esclusivo interesse del lettore e con trasparenza, rivolgendosi a chi ha bisogno di mediazione. Una parte della critica, invece, è diventata un sostegno alla produzione, trasformandosi in un’attività collaterale sostenuta dalla stessa produzione che la considera un possibile veicolo pubblicitario. Questo tipo di critica, inevitabilmente, andrà in crisi. La critica vera, quella portata avanti da persone credibili, che esprimono giudizi la cui indipendenza è riconosciuta, non entrerà mai in crisi.
Quale approccio narrativo ed estetico serve per parlare di vino alle nuove generazioni che cercano esperienze più immediate e immersive? Quali messaggi funzionano e quali errori evitare?
Il primo errore da evitare è affermare che il vino faccia bene. Il vino fa male, come tutte le sostanze che contengono alcol, indipendentemente dalla quantità ingerita. In una società che si muove molto velocemente verso una ricerca – talvolta illusoria, altre volte reale, ma sempre comprensibile – di genuinità e salubrità, il vino non può che incontrare difficoltà. Tuttavia, il vino ha una carta importante da giocarsi: è un grande, straordinario mediatore culturale. Il messaggio che dovrebbe essere trasmesso, ma che troppo spesso viene trascurato, è che studiando il vino, degustandolo in modo consapevole, nelle giuste quantità e modalità, si ha accesso a una sorta di libro di testo. Il vino è un mezzo per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze: storiche, geografiche, estetiche e persino filosofiche. È l’unico elemento della nostra dieta con così tanti riflessi culturali. Rivolgendosi alla fantasia, alla curiosità e all’intelligenza dei giovani, bisogna far capire loro che il vino non è una semplice bevanda. Non è corretto comunicarlo come la “bevanda della festa” o dell’aperitivo, da consumare con leggerezza. Dandogli la giusta importanza, come cerco di fare ogni giorno da quando ho iniziato, il vino può diventare qualcosa di non dico irrinunciabile, ma certamente indispensabile come lo sono i libri o i film.
Può funzionare introdurre elementi di rottura narrativa, magari ispirandosi a discipline come l’arte contemporanea, la musica o il cinema?
Sì, assolutamente. Il vino non è una forma d’arte, ma stimola gli stessi recettori che ci permettono di attivare la nostra percettività. Il senso estetico, infatti, viene sollecitato e stimolato dal vino proprio come accade con l’arte. Quindi, perché non creare dei cortocircuiti culturali tra queste due dimensioni? Io penso che questa sia la chiave.
Il tema sostenibilità è centrale nel vino. La comunicazione dovrebbe includere più temi etici e culturali per dialogare con le nuove generazioni?
A patto di non perdere di vista la competenza e la bravura nel realizzare il prodotto finale. Credo che nessuna scelta di carattere ecologico possa giustificare un prodotto mediocre. La sostenibilità, per molti, è già diventata una scelta obbligata e per alcuni territori lo è da tempo. Tuttavia, non può essere una semplice foglia di fico. È fondamentale preservare l’ambiente, perché un certo modo di concepire l’agricoltura – ormai, per fortuna, tramontato – ha in passato causato difficoltà e in alcuni casi veri e propri danni. Ma accanto alla sostenibilità agricola deve esserci anche la ricerca e la messa a punto di un prodotto esteticamente interessante. Non significa creare un prodotto perfetto, ma qualcosa che sia capace di stimolare la percezione, il senso estetico e il giudizio, un oggetto che coinvolga il pubblico a livello sensoriale e culturale. Questo è ciò che chiamiamo gusto, ed è una componente imprescindibile.
In un mondo dominato dai social, il racconto del vino può ancora puntare sulla forza evocativa del testo scritto?
Senza dubbio. Il testo scritto con qualità ha eguale forza narrativa e a volte persino superiore alle immagini. Ci sono testi sia di narrativa che di saggistica, con una tale forza evocativa derivata da un uso coltivato della lingua, da rendere l'immagine quasi banalizzante. Penso a ciò che si intravede nelle pagine di grandi descrittori di luoghi come Julien Gracq o Francesco Biamonti. Un testo scritto come dio comanda si farà sempre leggere.

Come valuta, nell’ambito della comunicazione del vino, il ruolo di chi lo produce? Le cantine comunicano bene?
Vedo di tutto: comunicazioni buone, molto intelligenti, molto sobrie; e comunicazioni aggressive nel modo giusto, che si fanno notare, con contenuti composti, ben strutturati e che centrano il punto. Dall’altro lato, ci sono però anche comunicazioni sguaiate e qualcuna persino molto discutibile e al limite del truffaldino. Per esempio, quando corrompi, direttamente o indirettamente, un critico che per mestiere assegna punteggi (sapendo bene che quel punteggio l’hai pagato) e poi questo critico ti concede il “punteggione” che ti aspettavi, la cosa non si ferma lì. Tu piazzi sulla bottiglia un bollino che dice “ho preso il punteggione X dal critico Y”. Questo equivale a un atto di concorrenza sleale che andrebbe perseguito per legge. In qualsiasi disciplinare italiano, senza eccezioni, è sancito il divieto di apporre sulla bottiglia menzioni laudative in etichetta o altrove. Quando queste menzioni te le sei addirittura pagate, diventa un comportamento “antisportivo”. Questo è, a mio avviso, l’esempio peggiore di comunicazione nel mondo del vino: è eticamente molto discutibile e dovrebbe essere punito e mai consentito.
Come immagina il racconto del vino tra vent’anni? Sarà più legato al passato o si evolverà verso una visione più universale, slegata dal terroir?
Spero che non si sleghi mai da concetti come il terroir. Confesso di non avere assolutamente idea di come sarà tra vent'anni, così come vent'anni fa non avevo idea di dove saremmo stati oggi. Ho sempre cercato di evitare il peccato di ritenermi tanto intelligente da poter prevedere il futuro. Preferisco viverlo momento per momento, giudicando le sue innovazioni passo dopo passo. Qualsiasi risposta dessi in questo momento sarebbe, con molta probabilità, sbagliata. Anzi, quasi certamente.