Le parole sono importanti. Quante volte, dopo l’uscita di “Palombella rossa”, abbiamo ascoltato questa citazione? Probabilmente, talmente spesso che non ci fa più alcun effetto: tendiamo a considerarla un luogo comune, poco o nulla rilevante. Ed è un peccato, perché si tratta di un concentrato di verità particolarmente importante per chi si occupa professionalmente di vino nel 2024.
Il linguaggio e la crisi
La crisi dei consumi, ma più ancora della popolarità del vino tra i più giovani passa anche, e molto, per una strada comunicativa e semiotica imboccata ormai alcuni decenni fa, sul cui abbandono vale la pena di riflettere oggi. Sì, vale la pena chiedersi se abbia ancora senso il lessico immaginifico, fatto di associazioni variegate tra le sensazioni del vino e quelle di altre forme assunte dall’ingegno umano, oppure le minuziose descrizioni dei mitici sentori, accostati a formanti che pochi o addirittura nessuno, nella propria vita, hanno avuto la ventura di incontrare.
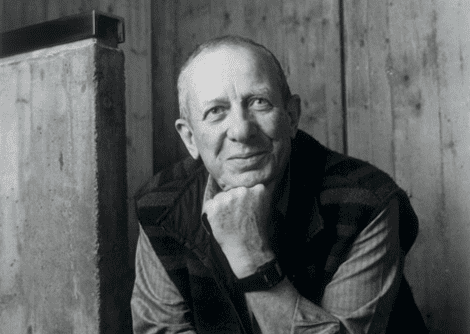
I neologismi, le perifrasi spericolate, le varie figure retoriche imperano nel racconto del vino da quando, all’inizio degli anni ’70, il modello Veronelli, in Italia, ha preso decisamente il sopravvento sul modello Soldati, nella comunicazione dell’“amato liquido” (a proposito di figure retoriche âgé…).
Quando guardiamo un documentario di Soldati o sfogliamo un volume di “Vino al vino” troviamo molta più attenzione antropologica al contesto in cui il vino nasce, rispetto alla cura tecnica nel dettagliare l’esperienza sensoriale che deriva dall’incontro con il vino del produttore o addirittura alla pretesa oggettivante della descrizione di tutto ciò che c’è nel bouquet, dalla a di acacia alla zeta di zest. Soldati ci appare persino primitivo nel parlare di vino. Questo perché il pioniere è stato sorpassato dal filosofo.

Con Veronelli, trionfa un lessico forbito, in costante via di arricchimento, ambiziosamente preciso nel restituire a parole le sensazioni olfattive e gustative: il connoisseur rimanda a immagini vivide, utilizzando un ampio vocabolario, persino insensibile ai vincoli della sintassi. Da lì sono discese molte delle forme che tutt’ora utilizziamo direttamente (scagli la prima pietra chi non ha mai affermato l’importanza di “camminare le vigne”) o per il tramite di ancor più spericolati epigoni (il “vino frutto”, ovviamente “polputo” appartiene allo stesso ambito creativo del “vino bandiera”).
I corsi che fanno danno
I corsi per sommelier, via via sempre più articolati a mano a mano che il mondo della formazione si segmentava, in ossequio all’italico genio per la frammentazione, hanno suggellato la necessità di apprendere un linguaggio, selezionando come formatori coloro che meglio lo padroneggiano (e che sono un piacere da ascoltare, lo ammetto in quanto Gen X).
Tuttavia, in quelle platee di wannabe sommelier, al termine di una giornata come operaio o insegnante, iniziava già a prendere forma il problema di cui qui ci occupiamo.
Quanti, giunti al termine del corso, di qualsivoglia associazione, padroneggiano davvero il vocabolario? Quanti di loro, usando a pappagallo il lessico iniziatico, spingono amici e conoscenti a desiderare di avvicinarsi al vino? E quanti invece, parlando una lingua che è divenuta troppo difficile per essere popolare - per questo risultando realmente padroneggiata da pochi - non generano piuttosto un desiderio di tenersi lontani da quella bottiglia, che richiede studio perché se non si comprendono tutte le sfumature delle tecniche produttive e degli aromi prodotti dall’affinamento, il bevitore è un buzzurro e addirittura il vino è sprecato?
Se sia possibile iniziare una de-escalation dalla costante specializzazione del lessico vinoso (ovviamente segmentato secondo le scuole in cui si dividono gli esperti e i relativi seguaci) è difficile dirlo. Più facile constatarne la necessità, invece, se si vuole provare a rendere nuovamente il vino una bevanda da godere e non un esame da superare.














