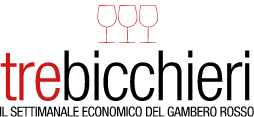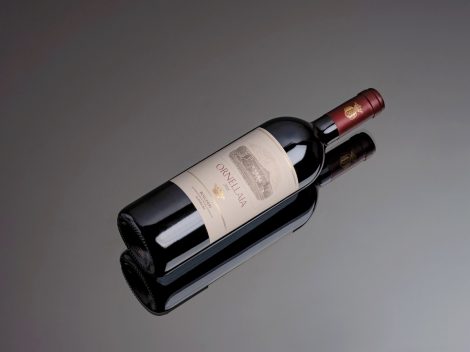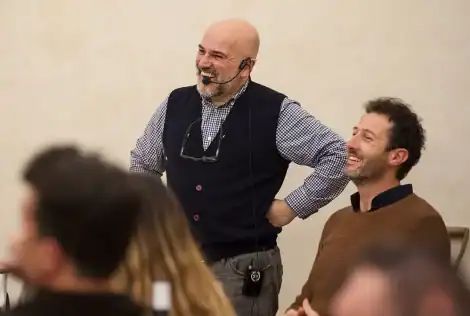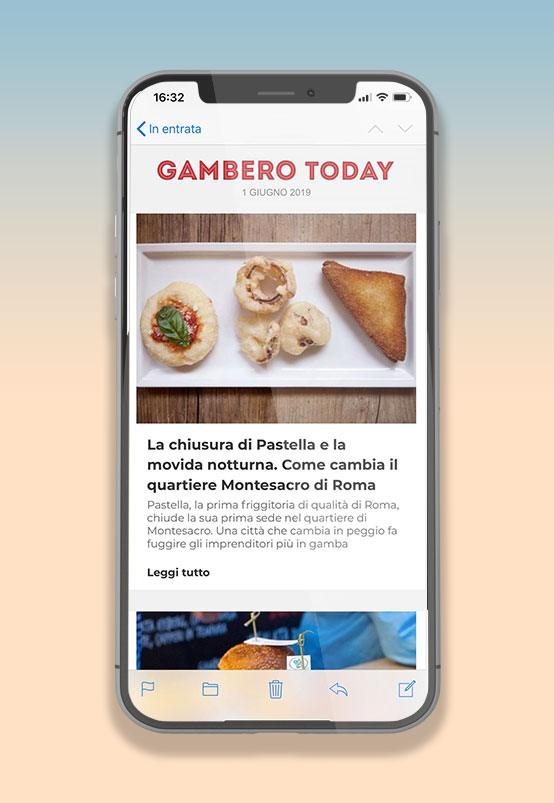Decine di pratiche arretrate sui disciplinari delle Dop e Igp sono sul tavolo del Comitato nazionale vini del Masaf. Ritardi che hanno spazientito non poco, e non pochi, Consorzi di tutela. Per l'organismo ministeriale, ufficialmente insediatosi lo scorso 28 gennaio, si apre un triennio, quello tra 2025 e 2027, denso di impegni per la quantità di lavoro e, soprattutto, per i nuovi compiti da eseguire. Ad esempio, dare supporto strategico al Masaf nelle politiche commerciali dei vini Made in Italy.
Ne è consapevole il presidente Michele Zanardo. Per l'enologo trevigiano, si tratta della seconda volta alla guida dell'organo ministeriale che sovraintende le 529 denominazioni del vino made in Italy. La prima fu tra 2018 e 2021, ma il Covid fece naufragare ogni buon proposito, prima del triennio appena concluso affidato al professor Attilio Scienza. Ora, l'obiettivo è fare presto. Non si può tergiversare. In un mondo produttivo che, per stare al passo coi tempi, ha bisogno di intercettare rapidamente nuovi consumatori e tendenze, e che potrà aprirsi anche ai dealcolati, sui quali Zanardo predica prudenza e approccio scientifico, le imprese non si possono permettere di restare indietro a causa della burocrazia. Come spiega in questa intervista al settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso, il Comitato Vini avrà funzioni allargate. E, per svolgerle, sfrutterà le numerose competenze al suo interno.

Nuovo Comitato Vini ma per lei è un ritorno. Il Masaf ha scelto - mi passi il termine - l'usato sicuro?
Ci sono dal 2008, quindi è un bel po' che frequento il Masaf. Nel triennio 2018-21, ero già stato nominato presidente. Dopo poco più di un anno abbiamo iniziato a lavorare molto online, a causa del Covid e ci siamo riuniti in presenza poche volte.
Possiamo dire che questa sarà una presidenza operativa?
Lo doveva essere anche quella del 2018 ma poi siamo entrati in pandemia. L'idea è quella di un coinvolgimento pratico di tutti.
Quindi, l'incremento delle segnalazioni e delle lamentele che come Gambero Rosso abbiamo raccolto da aziende e Consorzi da cosa deriva?
Il ritardo di questi anni è dovuto a un insieme di concause, da un lato, per qualcosa che si era accumulato durante l'emergenza Covid, per la ridotta operatività generale e, da un altro lato, c'è stato un aumento delle richieste da parte dei Consorzi. Voglio però precisare che per approvare un nuovo disciplinare, o una modifica, ci sono diverse fasi: una regionale, con una prima verifica delle amministrazioni competenti per territorio; una ministeriale, con un'istruttoria che coinvolge il Comitato Vini anche con funzioni di consulenza tecnica, a cui segue la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, con un periodo in cui possono essere presentati ricorsi e opposizioni sul disciplinare; infine, c'è una fase in capo all'Unione europea, in particolare per modifiche che impattano più a fondo sui cardini del sistema delle denominazioni.
Quante pratiche sono in sospeso? Siamo nell'ordine delle centinaia o delle decine?
Si tratta di qualche decina di pratiche, altrimenti sarebbe stato un disastro.
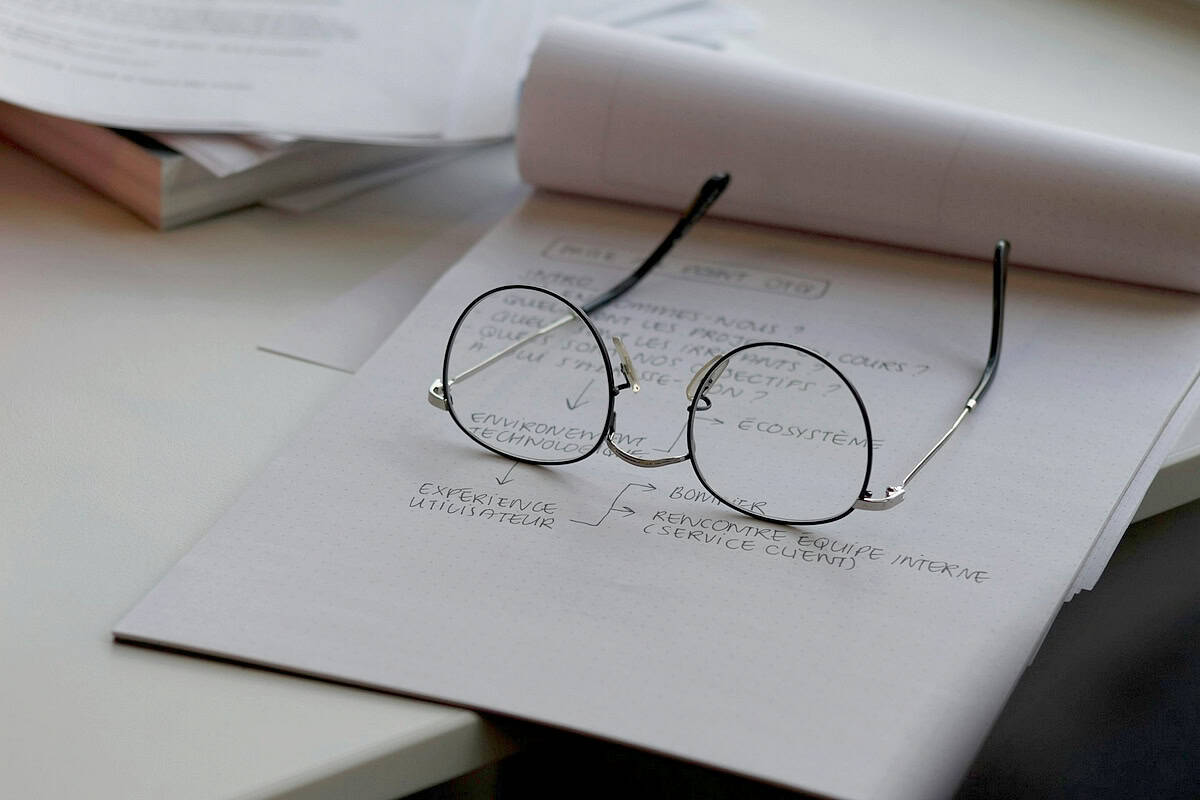
Tra le nuove sfide per il settore c'è quella dei vini no-low alcol. In Italia c'è il via libera. Per lei sono un rischio o un'opportunità?
Personalmente, da enologo, sono per valutare sempre in modo attento l'innovazione. Penso, però, che Dop e Igp significhino tradizione e prodotti unici nel loro genere. Ecco perché, secondo me, di Dop e Igp dealcolate, o parzialmente dealcolate, si dovrà riparlare quando ci sarà un'ampia sperimentazione, ovvero quando ci saranno prove che ci mostreranno come le caratteristiche dei vini non cambiano. In quel momento, potremo riprendere, serenamente, il ragionamento su Dop e Igp no-low alcol.
Molti grandi brand sentiti da Gambero Rosso spingono per lavorare sui dealcolati Igp.
Sì, ma ci sono altrettanti grandi brand che si interessano marginalmente ai dealcolati. Per essere chiari, concordo con l'impostazione del decreto Masaf che le esclude e dico che è corretto attendere i risultati pratici. Ricordo che lo spirito con cui l'Ue ha riconosciuto le Dop e le Igp del vino non è quello di derogare alle regole, ma quello di applicare pratiche enologiche tradizionali. La tutela di una Dop o una Igp, mi piace ricordarlo, funziona proprio perché le regole ci sono. Se, invece, si deroga alle regole allora si rischia di ridurre le tutele.
Alcuni Consorzi intendono, come il Prosecco, agire sulle tipologie esistenti in chiave low-alcol...
Il Consorzio del Prosecco sta facendo esattamente ciò che dicevo prima: sperimentazione. L'obbiettivo, mi pare di capire, è di dimostrare che si può mantenere la qualità del vino che oggi conosciamo. Lo stesso sta accadendo col Consorzio delle Venezie. Occorre consapevolezza e conoscenza. Non ci deve essere una presa di posizione a favore dei vini no-low alcol solo perché alcune componenti del mercato richiedono.

Insomma, lei predica prudenza e approccio scientifico
Forse l'errore di base è stato chiamare i dealcolati con il termine "vino". Fuori dall'Ocm Vino sarebbe stato tutto più semplice. Ricordo che il vino rappresenta la lunga storia di molti Paesi europei. Personalmente, ribadisco di essere aperto a tutto, ma vorrei avere dei risultati concreti anche sul prodotto finito.
Cosa ne pensa di vitigni resistenti e di Piwi. Al Senato, un disegno di legge propone la modifica del Testo unico del vino, introducendo anche nelle Dop i vitigni resistenti alle malattie fungine. Allo stesso tempo, il Pinot grigio intende diventare la prima denominazione con un resistente nel disciplinare
Anche qui, come per i dealcolati, sarei d'accordo nel vedere prima quali sono i risultati delle sperimentazioni in termini di aderenza alla tradizionalità sui prodotti Ddp. Inoltre, parliamo di numeri esigui: appena 900 ettari su 680mila totali coltivati in Italia. Mi sembra un po' un paradosso parlare di sostenibilità e di uso delle Tea, che a mio avviso sono il futuro, mentre allo stesso tempo si parla di dealcolati che sono agli antipodi della sostenibilità.

Altro argomento di attualità. Domenica scorsa, su Rai Tre, la trasmissione Report ha messo sotto accusa il Passito di Pantelleria, dopo essersi occupata di vino lo scorso anno, partendo dagli enologi, categoria di cui lei fa parte, e definendoli "piccoli chimici". Come si è sentito?
Ho visto tutte le puntate inerenti il settore. Da tecnico, ho analizzato ciò che hanno detto e, fra imprecisioni e prese di posizione di carattere ideologico, non ho trovato grandi argomenti su cui poter nemmeno discutere. Personalmente, penso che la categoria degli enologi, a cui orgogliosamente appartengo, possa andare fiera del quotidiano impegno finalizzato alla crescita del settore.
In conclusione, non ha apprezzato...
Ciascuno fa il proprio lavoro, c'è chi ritiene di farlo bene così ma c'è anche chi è libero di criticare. Ritengo che trasmissioni del genere spostino poco nell'opinione pubblica. Sono temi che interessano più gli addetti ai lavori, che ne hanno valutato, in particolare, imprecisione e tendenziosità. "L'uomo della strada" non parla di Report.

Torniamo al suo compito. In questo suo nuovo mandato, cosa prevedono le linee guida del Masaf?
Tra i compiti del Comitato Vini non c'è solo l'intervento sulle modifiche o sui riconoscimenti dei disciplinari Dop e Igp, ma anche una forma di supporto alla filiera vitivinicola come, del resto, è previsto dalla legge in vigore.
Però, questa è una novità importante.
Il ministro Lollobrigida intende coinvolgerci in un lavoro strategico, attraverso la fornitura di alcune linee guida generali per la tutela e valorizzazione delle Dop e Igp, in collaborazione con le strutture ministeriali e gli enti connessi.

Come mai questo ampliamento di competenze?
È un incarico di carattere strategico, dal momento che in Comitato siedono figure importanti del mondo del vino. Ci sono rappresentate, infatti, tutte le categorie e le principali associazioni. Si tratta di un modo per valutare al meglio lo stato dell'arte del settore vitivinicolo, oggi alle prese con una congiuntura particolare, con l'obiettivo di continuare a stare sul mercato in modo importante come l'Italia ha fatto finora. Di fatto è un inveramento delle competenze del Comitato previste dal Testo Unico del Vino.
In che tempi sarete operativi con funzioni strategiche?
Questione di qualche mese.
Vi dovrete riunire più spesso?
Probabilmente sì, cercheremo di fare riunioni in modalità mista, alternate a quelle in presenza.
Come farete a conciliare l'esigenza dello smaltimento degli arretrati?
Stiamo dialogando col Masaf in modo costante, perché dobbiamo recuperare il gap della dilatazione dei tempi di attesa per i disciplinari. La prima cosa è tornare a tempi di risposta funzionali alle aspettative della filiera vino. In particolare, stiamo ragionando su come rendere più efficace l'azione congiunta di Regioni, Masaf e Comitato.
Quali sarebbero i tempi corretti e ideali per la modifica di un disciplinare?
A regime, dovremmo arrivare a una risposta in 6 mesi per la procedura nazionale. Può anche però capitare che l'istruttoria di un disciplinare incappi in delle carenze sulla documentazione a supporto, con una successiva interruzione dell'istruttoria. In sostanza, più si è precisi nella presentazione della documentazione tecnica, a corredo della richiesta, e minori sono le interruzioni. Ci deve essere pertanto la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria, a partire dai proponenti.

Con l'entrata in vigore da qualche anno del nuovo iter europeo, è tutto davvero più snello?
Al di là delle competenze dei Consorzi e del peso dell'istruttoria nazionale, non ho notato misure che contribuiscano alla velocizzazione delle pratiche. Mi auguro, tuttavia, che le procedure Ue possano allinearsi alle mutate esigenze, non creando colli di bottiglia in sede comunitaria.