C’è una foto in bianco e nero, che risale al dicembre del 1968, solo pochi mesi prima della sua morte. Ritrae un gruppo di amici sorridenti, intorno a un tavolo apparecchiato. Più che mangiare, sembrano bere, hanno calici che ora si userebbero per i Martini e forse anche allora, anche se sul tavolo si scorge una bottiglia di Champagne ungherese e una birra. Ci sono Nunzia Monanni, l’ultima compagna, il figlio Alberto, Gabriel-la Bucher Scerbanenko, e la proprietaria del ristorante. Siamo al Tulipan, che si trovava in piazza Oberdan (Porta Venezia), all’angolo con via Tadino (oggi c’è la pizzeria Maruzzella). Un ristorante ungherese dove donna Rozal Brandis, cantante e pittrice, intonava canzoni popolari, accompagnata da un’orchestra tzigana, mentre i camerieri in costume si aggiravano nella sala in stile magiaro. Alberto Scerbanenko ricorda ancora la “giunonica bionda ungherese con una treccia delle dimensioni del mio avanbraccio”. Milano Tavola, una guida gastronomica edita da Bolaffi e pubblicata nel 1974 (a cura di Decio Canzio) loda il Tulipan, perfetto “per chi vuole provare un’ormai rarissima emozione operettistica, con il violinista che si contorce sul piatto di gulyas per inondarvi di note lacrimose”. Un posto speciale, dove mangiare zuppe di crauti, aringhe alla Bismarck, filetto all’Esterhazy, il tutto inondato da bianchi del Balaton.
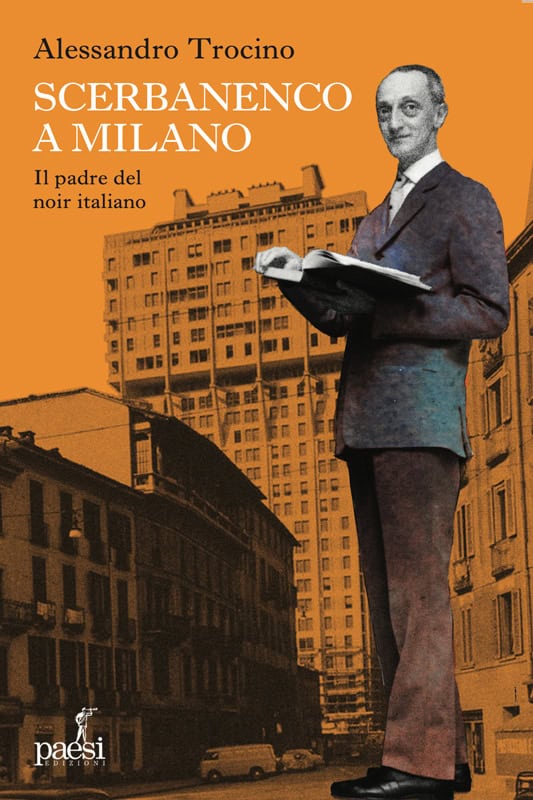
La copertina del libro di Alessandro Trocino
Il primo ristorante cinese
Non sono questi i piatti di cui si parla nei libri di Scerbanenco. Anche perché la cucina straniera negli anni Sessanta era appena arrivata a Milano. Il primo ristorante cinese, in ritardo rispetto a Roma, apre il 2 ottobre del 1962, La Pagoda, in via Fabio Filzi, recensito da un entusiasta Dino Buzzati sul Corriere della Sera. Dodici anni dopo, nella guida Bolaffi, sul centinaio di locali recensiti sono segnalati tre cinesi (via Canonica e via Solferino), due ungheresi, due francesi, un greco, uno spagnolo, un iraniano e un giapponese. Scerbanenco frequentava, e citava nei suoi romanzi, locali che in alcuni casi ci sono ancora o non ci sono da pochi anni. Uno dei preferiti era la Tavernetta di Elio, un ristorante toscano in via Fatebenefratelli. Qui cenò per anni anche Indro Montanelli, sin dalla fondazione del Giornale, che aveva la prima sede a pochi passi, in piazza Cavour. Con il proprietario, Elio Niccolai, discuteva dei fagioli di Sorana, della ribollita, e ospitava al suo tavolo il bel mondo della politica e del giornalismo, con annessi filibustieri di ogni genere. Negli ultimi anni della sua vita, ho visto un paio di volte Montanelli entrare da solo da Elio, per mangiare una minestrina serale. Scerbanenco ci andava invece con la compagna Nunzia Monanni, ma anche con le scrittrici Milly Dandolo e Brunella Gasperini, con il disegnatore del Bertoldo Giaci Mondaini, padre di Sandra, con i giornalisti Emilio Radius, i fratelli Sprea e Camilla Cederna. E con Vittorio Buttafava, che lavorava con lui a Novella, e che avrei letto alla fine degli anni Settanta nei suoi taccuini agrodolci – La vita è bella nonostante, Una stretta di mano e via – pieni di massime malinconiche e con in copertina i tram arancioni dell’epoca. Scerbanenco si concedeva spesso Bice, aperto ancora oggi, già allora considerato chic.

Il ristorante Bice in via Borgospesso. In apertura, la vecchia Alemagna all'inizio degli anni '50
Bice, una tavola chic
La prima sede la apre Bice Mungai, arrivata da Chiesina Uzzanese nel 1928 in via San Pietro all’Orto, con l’insegna di Gino e Bice. Nel 1939 si trasferisce in via Borgospesso, a due passi da via Manzoni, e diventa il luogo preferito di personaggi noti, come Montanelli, Spadolini, Mastroianni, Gassman, Vittorio De Sica. Già nel 1974, la guida Bolaffi contesta una cucina che sembra “vivere di rendita”, con i tre figli Remo, Roberto e Loretta “che rimangono un po’ nell’ombra come comparse poco convinte”. La Bice, scrive, “coccola i rampolli della Milano bene, che sfruttano i conti aperti dai genitori habitués del locale, con la sapiente dolcezza di una nonna comprensiva”. L’atmosfera è “cordialona” e il menu è toscanissimo, con i classici dell’epoca: l’immancabile ribollita, i fagioli all’uccelletto, la trippa alla fiorentina, le scaloppe al Camembert e, per finire, quiche lorraine, il tutto innaffiato da Chianti sfuso. Il prezzo medio nei primi anni Settanta era di 5 mila lire e tra i comfort era citata la “teleselezione”. Bice è scomparsa nel 1996 e ora in sala ci sono le nipoti Roberta e Beatrice Ruggeri. La cucina, guidata da Vincenzo Mazzone, non è più toscana, ma è debitrice soprattutto degli anni Ottanta. Si trovano piatti come i gamberi rosa al vapore in salsa cocktail (35 euro). La Bice è citata anche in Traditori di tutti, in una tradizione che non è molto frequente in Italia: per ragioni incomprensibili, spesso legate a un malinteso tentativo di sottrarsi a derive pubblicitarie, si preferisce da noi non menzionare luoghi e oggetti veri, finendo così per risultare posticci, con protagonisti che si aggirano in scena e nei libri con giornali improbabili sottobraccio e mangiano in ristoranti veri dai nomi camuffati.

L’atmosfera “cordialona”
Scerbanenco rompe questa tradizione un po’ ipocrita, perché ha bisogno di realtà, vuole stare vicino alle cose, far sì che il suo lettore si immedesimi e con la stessa acribia con la quale racconta la toponomastica milanese, descrive alcuni suoi locali e protagonisti. Come la Bice, che serve i liquori, si siede con i clienti, li chiama commendatori, lusingandoli, anche se non lo sono, e quando criticano la carne, sorride e cambia discorso. È un’atmosfera “cordialona” davvero, con la proprietaria che si siede ai tavoli con i clienti, come accadeva al Tulipan, e scherza, ride, beve con loro. C’è un altro locale che fa la sua apparizione in Traditori di tutti ed è il bar pasticceria Ricci, aperto nel lontano 1938 e poi chiuso nel 2017, dopo diverse avventure, la trasformazione in un bar gay friendly glamour (come si diceva negli anni Ottanta) e un ultimo tentativo disastroso di riportarlo ai fasti di un tempo, con nuovi soci, tra i quali Joe Bastianich e Belen Rodriguez e un menu cafonal, tra hamburger e lobster roll. Nel romanzo ci va Duca Lamberti: “Sull’immagine della ragazza distesa nella cella frigorifera si disegnarono più nitidi i banchi di quel venerando tempio dell’Alta Dolciaria, dell’Alta Ora del tè, Alta Sera dell’Alto Gelato, dove mezza Milano, o tutta?, veniva appena poteva per il rito dell’aperitivo, per la cartocciata di paste che i mariti portavano a casa alla moglie e ai bambini alla domenica, e le bottiglie di vino francese, greco, tedesco, spagnolo, esposte in una vetrina, un poco inclinate, liquidi gioielli difficili da intendere se uno aveva il palato abituato ai vini da pasto”. È una Milano internazionale, con vini di tutte le nazionalità, una Milano dell’abbondanza, opulenta, gaudente, golosa.

Milano, via Moscova ieri e oggi
La vecchia Alemagna e le tartine al salmone
Come l’Alemagna di via Manzoni, oggi Emporio Armani, che un tempo era un altro tempio della pasticceria, tra panettoni, meringhe e cioccolate con panna. In Venere Privata, dopo il giro al seguito delle “cooperatrici” (le prostitute), ci va Davide Auseri e trova un banco smisurato con le tartine all’uovo, al salmone, al caviale, e tutti quei pasticcini e gelati che danno un tono di Versailles e Tuileries all’ambiente, ma con una nota di modernità astratta che stona, l’aria condizionata gelida, che fa un’aria da montagna in città. Duca mangia tre tartine e beve una birra, distogliendo lo sguardo dalle commesse. Perché Davide è “sgocciolante di istinti” e guardare la commessa della pasticceria, con l’acconciatura gonfia, che manovra le praline, gli fa un effetto che è meglio non incoraggiare. Non è la sua unica tappa gastronomica, e sempre in luoghi moderni. Stavolta va al bar Milanese (esiste ancora) della Galleria Cavour, dove trova una bomboniera di caramelle, cioc-colatini, paste e una birra gelata, che tracanna subito. La stessa opulenza raccontata più avanti, nella stessa zona.
I paciosi, efficienti, ambrosiani passeggiano con i loro loden verdi, i cappelli dalle larghe tese e nulla sanno dei traffici di droga, di un uomo che colpisce la moglie con ventisette coltellate, non sanno che là fuori “tutto va sudiciamente male” e se ne stanno all’Hotel Cavour (anche questo è sopravvissuto, su via Fatebenefratelli), tra vassoi opulenti, colmi di tartine e panini, i grissini con il prosciutto dolce di San Daniele avvolto intorno e le vaschette di burro nel ghiaccio, il paté in gelatina e perfino le bottiglie di birra nel secchiello d’argento. La città già modernissima, e un po’ cafona, anticipa la Milano da bere e alterna forme di resistenza tradizionali a slanci di futuro.

Tradizione e futuro
Nel racconto Basta col cianuro, in Milano Calibro 9, il protagonista sta in una pizzeria di viale Lombardia e mangia un piatto di nervetti, tirando su con la forchetta lunghi riccioli di cipolla cruda, e quando arriva la ragazza la rimpinza con pizza con i funghi, profiterole, Verdicchio e grappa con la ruta. Il menu del Piccolo hotel per sadici, dalla raccolta Milano Calibro 9, è un bel memoir del tempo passato: assiette di caviale e salmone – doppio ristretto di manzo con crostini – pollo alla cosacca con tartufi – formaggio, frutta e gelati casarecci. I due vecchi lupi protagonisti del racconto, prima di squartare con coltellacci e scalpelli a lama e sega una ragazza di ventisei anni, ci danno dentro, con l’appetito lussuoso della borghesia emergente e marcia. Qui c’è un salto di qualità anche nella sfarzosità del banchetto, con le ostriche adagiate sul ghiaccio tritato in un vassoio d’argento, un piatto di cristallo con i quartini di limone disposti a elicoide, le pepiere d’argento, il vino bianco coquillage nel secchiello.
La ragazzina Adri si aggiusta la vestaglia e prepara le ostriche al gusto di allora, con molto pepe e molto limone e comincia a distribuirle una per ciascuno, come una geisha destinata a una brutta fine. È un periodo così, si scoprono i cibi raffinati, il lusso, le ostriche, mentre i grandi chef sono cuochi ambiziosi e inadeguati, che sperimentano battute di cervo all’imperiale con arance della California macerate nel rum, ma che poi finiscono per sbagliare i piatti più semplici, e trasformano due uova al tegame in una frittata. Non c’è ancora il chilometro zero, come si evince dalle esotiche arance californiane, ma c’è già una subalternità al lusso d’importazione. Franco Gnoli ha raccontato che con Scerbanenco andava al Bar Vittorio Emanuele, sotto la Galleria, e prendevano l’Opaline, un liquore azzurrognolo a base di anice. Di fianco all’esterofilia imperante, ai profiterole, al coquillage, alle ostriche con tanto limone, convive però la vecchia Milano povera di una volta. L’osteria con l’aria che sa di segatura umida, l’odore della zuppa di verdure che sale dalle scale, i fiaschi di Frascati e di Orvieto, il panino con le olive nere, il pollo con i funghi, la sambuca con il chicco di caffè, la Barbera, le fettuccine al ragù, i panini con wurstel e crauti della Croita Piemunteisa, la pasta e fagioli che era ancora una minestra di fagioli, la china liscia, le conchigliette al burro, il formaggio duro con la lacrima del lodigiano, il panettone del bar Frontini, l’insalata alla marinara, il pollo freddo, il Centerbe, il biancostato, le insalate di peperoni, la mostarda, i maccheroni gratinati comprati dal salumiere di via Vitruvio.
1957, il primo supermercato a Milano
Ci sono cose più esotiche, come il kirsch, l’ananas acquistato nel supermercato di viale Regina Giovanna, che poi è l’Esselunga di Caprotti, il primo aperto in Italia, nel 1957. C’è il prosciutto in scatola, testimonianza della modernizzazione dell’industria conserviera dei cibi. Ci sono il whisky Mackenzie, il cocktail con l’uovo, il vino bianco bevuto con seltz e limone. È una Milano che esce dalla povertà e prova ad adeguarsi, i trani, osterie autentiche che si travestono da bar, sostituendo i tappeti verdi sui tavoli con ripiani di plastica, modernità appiccicosa. Tra le righe, si coglie già una critica a questa Milano finto moderna, un po’ bauscia. Del resto, lui odiava da sempre l’esibizione, come scrive in un ironico e fulminante autoritratto sulla rivista Il Milione, nel 1939: «Giorgio Scerbanenco è benevolo e indulgente verso molte cose e molte persone, ma detesta le riunioni mondane, l’ostentazione e lo snobismo. Trascinato a un pranzo di gala dove i padroni di casa esibivano le loro ricchezze, il loro lusso, e gli ospiti affettavano di non toccare quasi le vivande, stufo di vedersi mettere sotto il naso stoviglie preziose, ma quasi vuote, disse forte: gradirei ancora un cucchiaino d’argento di risotto». C’è perfino una citazione dei vegetariani, in un racconto di Milano Calibro 9, Quando una donna piace forte, dove racconta che la Fiera di Milano era piena come un filobus nell’ora di punta a causa dei fieraioli vegetariani, che assediavano i tavoli per mangiare. Ma c’è già anche, incredibile a dirsi, una critica della finta tradizione, di chi fa del passato una moda, censurabile come il modernismo a tutti i costi.

Gastronomia e crimine
E così in Traditori di tutti, Duca arriva alla Certosa di Pavia (sorta di prolungamento della città metropolitana) e trova sul piazzale un paio di osterie: “Scelse la meno rustica, non si fidava della rusticità”. Ma le cose non vanno bene ugualmente: “Al ristorante non rustico, con qualche tentativo di modernità e di eleganza, là, davanti alla chiusa Certosa di Pavia, la cosa più difficile fu ot-tenere due panini con salame e peperoni sottaceto, non si volevano abbassare a questi piccoli servigi, barista, cameriere e padroncina alla cassa tiravano in lungo”. Duca deve sfoderare la sua autorevolezza, insieme al tesserino di poliziotto, per ottenere “subito, non a Ferragosto” due panini con salame e sopra una fettina di peperone sottaceto. Ordine eseguito, ma il risultato non è soddisfacente: “Il salame era molto discutibile, e il peperone, più che di aceto, sapeva di acqua ragia, ma non aveva colpa nessuno, vero?”. La gastronomia come il crimine, degrado delittuoso senza colpevoli. In Traditori di tutti, Duca e Mascaran-ti vanno alla trattoria Prospero e devono ripulirsi dal sapore amaro delle “male piante”, tipacci capaci di ammazzare dieci persone e che poi, soltanto perché considerati “malaticci”, vengono spediti a Nervi a passeggiare, respirare aria salmastra e sorbire zuppa di pesce. Duca e Mascaranti no, non sono così, sono uomini veri, non malaticci, non feccia e si capisce anche dal menu. E così mangiano “da maschi”, spaghetti alle vongole, filetti di merluzzo fritto e formaggio pecorino.
Il fagiolino di Inverigo
A Inverigo, nel romanzo, c’è una signora che toglie il filo ai fagiolini, a mano. Duca sta parlando con Livia, la rabbia in corpo per quel viso sfregiato, per quella donna rovinata e reietta, per colpa sua, che l’aveva sacrificata, e dei criminali. Parla e guarda la signora che lavora, poi segue un suo istinto. Ricambia il sorriso alla donna dietro la cassa, prende un fagiolino e lo schiaccia tra le dita, tanto per esercitare violenza su qualcosa. La legge proibisce la violenza, ma lui ne ha bisogno, e i fagiolini sono l’unico oggetto sul quale può scatenare la sua rabbia inerte, contro i traditori. Era un mondo in cui tutti tradivano tutti, per un gelato. Anche se era già un mondo che non si accontentava più del barbera, come allucinogeno, erano passati alle bombe e alla mescalina. Si ubriacavano con l’anice lattescente, un liquore prodotto in Sicilia, una sorta di sambuca con spirito di vino e cumino. Nei Ragazzi del massacro è la bevanda da settantotto gradi che produce eretismo psichico e che, con l’aiutino dell’anfetamina, li spinge alla violenza efferata contro l’insegnante. Il fiasco di vino è ormai il ricordo romantico di un mondo sparito.














